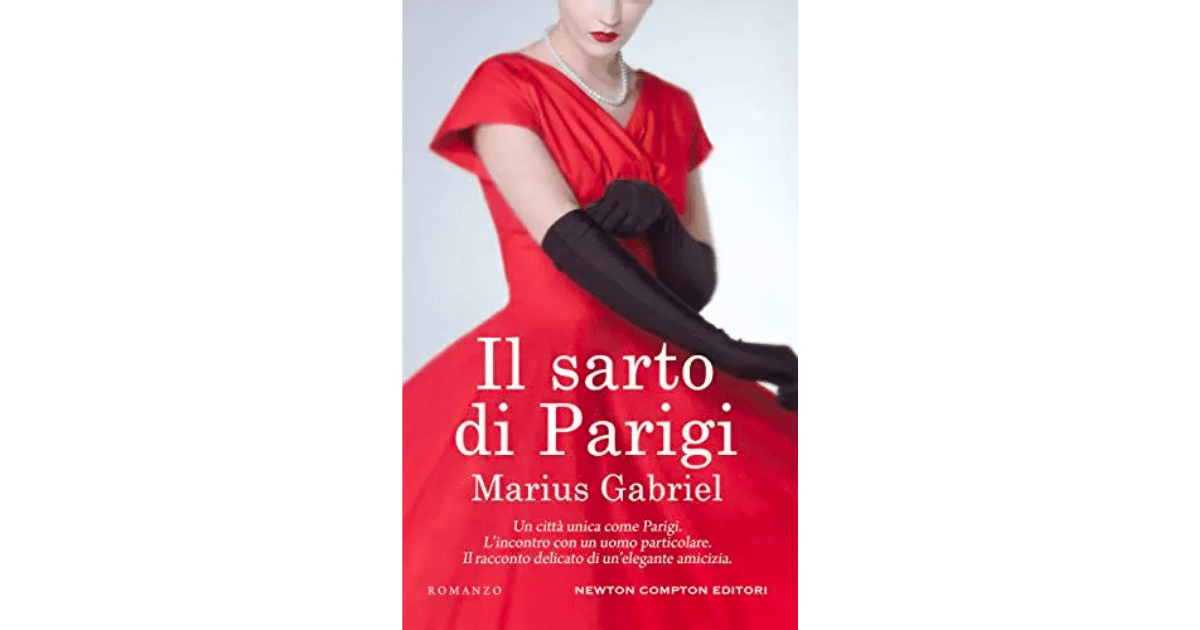Ho esaminato la classifica redatta da Mondadori contenente i cento libri più venduti in Italia (2017). Dei titoli stranieri, ho notato come moltissimi siano rimasti non tradotti. È una tendenza sempre più diffusa, soprattutto se il pubblico di riferimento è composto da young adults, a cui è dedicato un numero enorme di saghe e romanzi, soprattutto fantasy o di fantascienza. Spesso il titolo originale è costituito da un’unica parola: è il caso di Divergent (“Divergente”), Twilight (“Crepuscolo”), Red (“Rosso”), Maze Runner (letteralmente: “Il corridore del labirinto”). I giovani oggi hanno più dimestichezza con l’inglese, e spesso il titolo originale abbinato a una copertina elaborata risulta più moderno e interessante della traduzione italiana. Nella maggior parte dei casi, se non rende bene la traduzione letterale (come “La strada” –The road-, di Cormac McCarthy, 2007; “Il mondo conosciuto” –The known world– di Edward P. Jones, 2004; “L’atlante delle nuvole” –Cloud atlas– di David Mitchell, 2014) si lascia il titolo così com’è nella lingua di partenza. Interessante è il caso di So the Wind Won’t Blow It All Away, di Richard Brautigan, scritto nel 1982. Nell’edizione italiana si è deciso di cambiare il titolo originale con un altro inglese. Letteralmente il titolo inglese è “Così che il vento non soffi via tutto”; fu pubblicato nel 2005 da Isbn con il titolo American Dust, più immediato e facile da ricordare: nel testo un ritornello ritorna spesso, «Prima che il vento si porti via tutto / Polvere… d’America… Polvere». A volte invece, i libri sono stati rititolati a seguito dell’uscita nelle sale delle loro trasposizioni cinematografiche: è successo per esempio con I Am Legend di Richard Mateson, che era stato tradotto con I vampiri prima di diventare Io sono leggenda. Do Androids Dream of Electric Sheep?, di Philip K. Dick, fu tradotto in italiano con tre differenti titoli, a seconda dell’anno di uscita. Intitolato dapprima Il cacciatore di androidi, è stato poi edito con lo stesso titolo del film che ne è stato tratto, Blade Runner, per essere successivamente ritradotto e ripubblicato nel 1996 con un titolo più aderente all’originale, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? edito da Fanucci Editore, e come sottotitolo “il romanzo da cui è stato tratto Blade Runner”. Altro caso di titolo influenzato dal film è Revolutionary Road, (Richard Yates, Minimum Fax, 2017). Minimum Fax ha deciso di mantenere il titolo originale dopo l’uscita del film con L. Di Caprio e K. Winslet nel 2008, che lo ha riportato alla ribalta. Nel 1964 questo libro era uscito in Italia con Garzanti con il titolo I non conformisti: si riferiva ai protagonisti, April e Frank Wheeler, che sognano una vita diversa rispetto a quella provinciale e piatta che conducono. Era però anche un rimando al romanzo Il conformista di Alberto Moravia (1951). Anche Shining, di Stephen King, è un caso di libro rititolato dopo l’uscita del film. La prima edizione italiana lo aveva tradotto nel 1978 come Una splendida festa di morte.
Altri esempi di titoli lasciati originali sono:
-Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, Supercoralli, 2014: ricorda la pronuncia africana del termine inglese, che anche in italiano rende il suono. (la protagonista, come l’autrice, è nigeriana)
-Marilynne Robinson, Gilead, Supercoralli, 2008: è la cittadina di ascendenza biblica situata nel cuore dell’Iowa dove è ambientata la trilogia.
-George Saunders, Pastoralia, Einaudi, 2001: è il titolo del primo dei racconti che compongono il libro.
-Don De Lillo, Underworld, Supercoralli, 1999: durante la narrazione viene fatta un’allusione che spiegherebbe il titolo del romanzo. Si riferisce ad un immaginario film di Ejzenštejn degli anni trenta, ritrovato dopo decenni e proiettato per la prima volta nel 1974 dalla cerchia di artisti di New York amici di Klara Sax. Il film si chiama Unterwelt, traduzione tedesca di Underworld.
Molti titoli inoltre sfruttano giochi di parole o modi di dire tipici della cultura di partenza, che nella lingua di traduzione perderebbero di significato. È il caso di I Love Dick, di Chris Kraus, Neri Pozza, 1997: il libro si è fatto un portavoce della libertà sessuale delle donne, a partire dall’allusione contenuta nel titolo (Dick è il nome di uno dei personaggi e un termine gergale per il membro maschile; tradurlo in italiano avrebbe voluto dire perdere questo gioco di parole).
Ci sono titoli, invece, che sono stati tradotti in modo completamente diverso dall’originale:
-John Grisham, La grande truffa, Mondadori, 2018 – Titolo originale: The rooster bar. Il titolo si capisce grazie alla trama: gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge di Washington pieni di sogni e voglia di impegnarsi, ma dopo essersi coperti di debiti per poter pagare le rette salatissime si rendono conto di essere oggetto di una grande truffa. Il loro istituto è uno dei tanti nelle mani di un potente e losco investitore newyorchese, che è anche socio di una banca specializzata nella concessione di prestiti agli studenti. Decidono a loro volta di farsi truffatori per farla franca con i grossi debiti accumulati e vendicarsi del torto subito: per fare ciò devono lasciare subito gli studi, fingere di avere i titoli per praticare la professione di avvocato, ed eleggono il Rooster Bar, dove si incontrano abitualmente, a loro quartier generale. In inglese la parola bar non indica solo pub, locale, ma anche la sbarra degli imputati in tribunale, e bar exam è l’esame per diventare avvocato che i tre protagonisti decidono di non dare. In italiano non è possibile rendere la carica di questo gioco di parole, perciò, secondo me, si è optato per un titolo altrettanto ambivalente (la truffa di cui sono vittime gli studenti e la truffa che decidono di attuare ai danni di chi li ha imbrogliati) che rende molto bene le intenzioni originarie dell’autore.
-Fred Vargas, Il morso della reclusa, Einaudi, 2017; il titolo originale francese è Quand sort la recluse, che letteralmente significa “quando esce l’eremita”. La trama infatti ruota intorno a tre misteriose uccisioni attribuite al morso del ragno eremita, della specie Loxoceles reclusa, che in realtà nascondono ben altri misteri. In italiano un thriller intitolato “Quando esce l’eremita” non risulta tanto accattivante quanto la scelta finale fatta da Einaudi.
-Jennifer L. Armentrout, Per sempre mia, Nord, 2017 – il titolo originale è Till Death, “Fino alla morte”; mi sono chiesta perché non tradurlo tale o “Per l’eternità”, poi leggendo la trama ho trovato un senso alla scelta, purtroppo senza riuscire a verificare se sia effettivamente stata guidata da queste intenzioni. L’autrice scrive tipicamente romanzi rosa; in questo libro ha mescolato elementi di giallo e thriller a una storia d’amore che si riapre dopo dieci anni. La protagonista del libro è riuscita a fuggire da un killer che la teneva prigioniera, e ritrova un vecchio amore che ora è un agente del Fbi. Il killer continua a perseguitarla, da un lato, e allo stesso tempo si riaccende la fiamma con il poliziotto. Il titolo può riferirsi sia al killer, che la cerca per ucciderla e tenerla per sempre con sé, sia all’agente innamorato di lei che la vuole proteggere a costo della vita. Trovo la scelta azzeccata visto il genere di cui l’autrice si occupa e che ha riscosso successo proprio tra il pubblico femminile.
-Nicholas Sparks, Ricordati di guardare la luna, Frassinelli, 2006. Il titolo originale è Dear John: nella cultura popolare statunitense l’espressione “Dear John” sta a indicare una lettera nella quale una moglie comunica al proprio marito, solitamente un militare, la volontà di divorziare da lui. John è un nome generico che sta ad indicare tutti gli uomini in questa situazione, anche se coincide con il nome del protagonista del libro in questo caso. La trama infatti ruota intorno alla travagliata storia d’amore tra John, un militare in carriera, e Savannah: i due per anni si scrivono lettere, in una delle quali si promettono “Ovunque sarai e qualunque cosa stia accadendo nella tua vita, tutte le volte che ci sarà la luna piena tu cercala nel cielo…” da qui il titolo italiano.
–Suzanne Collins, Il canto della rivolta, Mondadori, 2012. Titolo originale: Mockingjay, “Ghiandaia imitatrice”). Il romanzo è l’ultimo della trilogia Hunger Games. La “ghiandaia imitatrice” del titolo è una specie di uccelli inventata, si tratta di un ibrido fra il mimo e la ghiandaia, uccelli realmente esistenti che nei romanzi, in seguito a esperimenti di laboratorio, si sono fusi. Anche il corrispettivo inglese è inesistente, ed è un ibrido linguistico fra mockingbird (mimo) e jay (ghiandaia); il verbo to mock, infatti, significa imitare. Se si aggiunge che “Ghiandaia Imitatrice” è l’appellativo assegnato a uno dei protagonisti. Per mantenere in qualche modo un legame con l’originale inglese e con l’appellativo del personaggio, l’edizione italiana ha scelto “canto”. Infine, visto che il romanzo ruota attorno a una rivoluzione, si è arrivati a “rivolta”.
-Jennifer Egan, Il tempo è un bastardo, Minimum Fax, 2010. Nel 2011 ha vinto il Pulitzer per la narrativa. Il suo titolo originale è A Visit from the Goon Squad: letteralmente, “goon squad” significa “banda di picchiatori”. Uno dei messaggi trasmessi dal libro è appunto che il tempo è “uno che picchia duro e a tradimento”. Il titolo italiano è tratto dal libro, dove compare più volte l’espressione «time is a goon», «il tempo è un bastardo».
-Harper Lee, Il buio oltre la siepe, Feltrinelli, 1962: in inglese il titolo è To Kill a Mockingbird, che letteralmente significa “uccidere un mimo”. Si riferisce al tordo americano, l’uccello che si vede sulla copertina dell’edizione italiana e che non vive in Italia. Il titolo originale fa riferimento a una scena in cui Atticus, il padre della narratrice, dice a lei e al fratellino di non sparare ai passeri (mockingbird è stato tradotto in questo modo per rendere comprensibile la scena ai lettori italiani). Il titolo Il buio oltre la siepe invece viene da un altro passaggio del romanzo: i bambini protagonisti non sanno cosa ci sia oltre la siepe che delimita il confine della loro casa e per questo ne hanno paura.
-Agatha Christie, Dieci piccoli indiani, Mondadori; scritto nel 1939, è il giallo più venduto al mondo. Il titolo originale inglese, sia della pubblicazione a puntate che di quella in volume, era Ten little niggers. In America, però, il termine nigger fu considerato offensivo nei confronti della comunità nera, per cui il titolo fu cambiato in And then there were none (corrisponde all’ultimo verso della filastrocca Ten Little Indians che viene citata alla fine del libro). In Italia, il romanzo fu pubblicato da Mondadori nel 1946, con il titolo “…E poi non rimase nessuno”, successivamente trasformato in Dieci piccoli indiani, ritenuto più musicale.
-Oscar Wilde, L’importanza di essere Franco, Rusconi, 2007. Celebre è il dibattito sulla resa italiana di questo gioco di parole: in inglese l’aggettivo “earnest”, che significa “onesto”, si pronuncia come il nome “Ernest”, cioè “Ernesto”. Uno dei personaggi finge di chiamarsi così perché la donna di cui è innamorato vuole sposarsi con un uomo che si chiama appunto Ernest. In italiano è tradotto sia con L’importanza di essere onesto sia con L’importanza di chiamarsi Ernesto, ma nessuno dei due titoli conserva il gioco di parole. In passato fu tradotto anche con L’importanza di essere Onesto/Probo/Fedele.